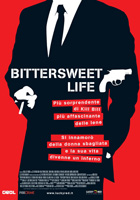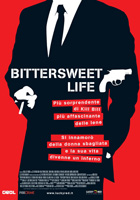Sunwoo
è un gorilla impeccabilmente vestito e vagamente esteta
(non a caso la prima inquadratura lo ritrae in gessato mentre
gusta una sacher torta) al servizio del grande e spietato
boss Kang. Il rapporto tra i due e lo stesso di quello che
intercorre tra un figlio promettente, desideroso di crescere
secondo i dettami del padre, ed un genitore orgoglioso della
sua creatura.
L’idillio si rompe e gli eventi prendono una brutta
piega quando Kang incarica Sunwoo di sorvegliare la sua giovane
e sensuale fiamma (del peccato?) di nome Heesoo, con espresso
ordine di freddarla nel caso di fragrante adulterio. Heesoo
è una finestra aperta su un campo fiorito, con la sua
delicata sensualità e la voglia tutta giovanile di
divertimento e leggerezza; ovviamente, come da manuale, Sunwoo
ne rimane incantato e quando scopre la magagna (l’adulterio)
dà in escandescenza ma lascia sostanzialmente impuniti
i due amanti galeotti. Agendo di testa propria, contravvenendo
al supremo ordine del padre-padrone, egli rovina vertiginosamente
dalla posizione di fidato braccio destro a quella di ultimo
dei servi, in un rovesciamento dialettico che lo priva, agli
occhi del boss, di umanità e dignità. Umiliato,
straziato, torturato dagli sgherri suoi ex-amici, subisce
un seppellimento prematuro dal quale emergerà soltanto
grazie ad un insaziabile sete di vendetta, deciso a punire
l’artefice/artefici della sua caduta. Il regista Kim
Jee-Woon (The Quiet Family, A
Tales of Two Sister) mette in scena un opera dall’andamento
ellittico, con incipit e prologo nel lussoso e modernissimo
salone d’hotel in cui Sunwoo svolge la mansione (pura
facciata) di direttore, intrisa di atmosfere melò e
riminiscenze noir; tutto quanto mescolato e raffinatamente
confezionato alla maniera coreana. Bittersweet
Life, rifiuta sia l’etichetta di film di genere
sia quella, a volte abusata, di noir. Se da un lato il personaggio
di Sunwoo ammicca al Delon tenebroso, schivo ed atteggiato
delle pellicole di Jeanne Pierre Melville (Frank
Costello, Faccia d’Angelo,
Les Samurai), apparendo inconfutabilmente
noir, dall’altro con il procedere dell’intreccio
diviene palesemente avvertibile, a livello di sceneggiatura,
l’inconsistenza della caratterizzazione. Il triangolo
pessimismo-alienazione-esistenzialismo finisce per essere
intrappolato nelle reiterate sequenze da action-movie, che
seppur esteticamente notevoli, plagiano eccessivamente la
scuola di Hong-Kong ed il suo più celebre rappresentante
John Woo. Le coloriture noir si stemperano progressivamente;
il protagonista, chiudendosi in un mutismo impenetrabile,
si limita ad esternare la propria sofferente condizione soltanto
attraverso il volto imbronciato; scarni e talvolta didascalici
i dialoghi che in un noir contano più delle scazzottate
(anche se qui trattasi di acrobatici combattimenti in stile
Bruce Lee) e delle rivoltellate. “Una pistola mostrata
troppo spesso è come un sipario calato troppo in fretta
su di un secondo atto scadente” diceva Raymond
Chandler per bocca della suo beniamino Philip Marlowe. Insomma
più che un film di genere, Bittersweet
Life assomma e compone ruffianamente molte differenti
visioni di cinema. In questo senso il finale è paradigmatico
risultando una commistione tra primi piani e suspence alla
Spaghetti Western, l’epico romanticismo dei rallenti
nello scontro finale alla The Killer,
una sapiente ed ironica orchestrazione della carneficina da
scontri a fuoco in stile Tarantino, il tutto accompagnato
da una musica che emula vergognosamente il tema deIl
Buono, il Brutto ed il Cattivo. Un film patinatamente
estetico, virtuoso a livello registico, appagante per gli
occhi quanto indifferente per il cuore. Sarebbe impietoso
definirlo come un superbo esercizio di stile, di certo non
guasta utilizzare un aggettivo mutuato dalla storia dell’arte:
manierista. [matteo burioni]